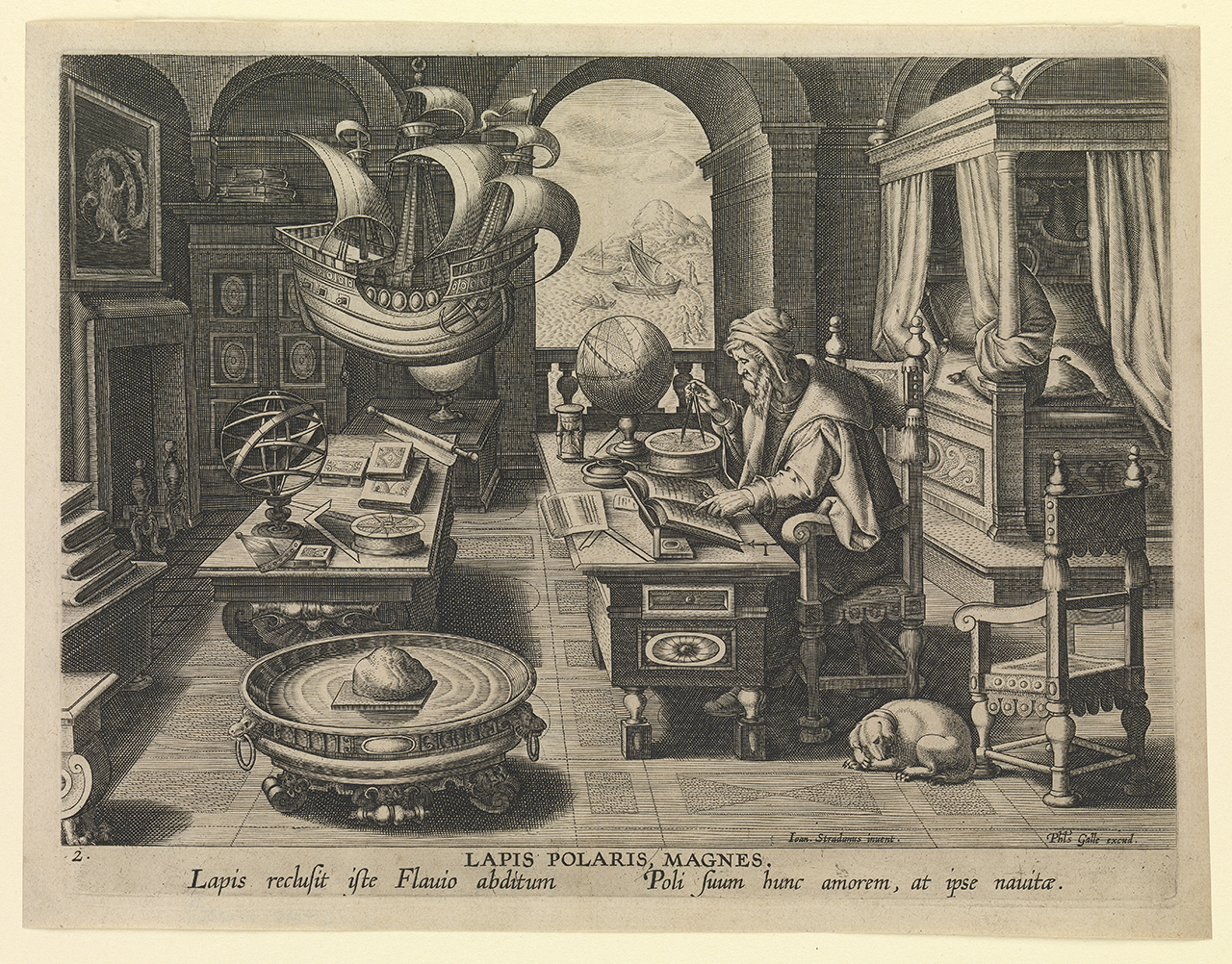
I. Ipersonno
Then he stared through the window
for long unbroken minutes at a time, but only at the
busy road, never the sky. And his face was not
the moon. And his hands were not the hands of a man
who had held between finger and thumb the blue
planet, and lifted it up to his watchmaker’s eye.
Poi guardò dalla finestra
per lunghi minuti ininterrotti alla volta, ma solo la
strada affollata, il cielo mai. E la sua faccia non era
la luna. E le sue mani non erano le mani di un uomo
che aveva stretto fra indice e pollice il
pianeta azzurro, e lo aveva portato al suo occhio di orologiaio.
(Simon Armitage, The English Astronaut)
È passato quasi un anno da quando lo scorso autunno è stato pubblicato Quaternarium (finito di stampare nel mese di settembre 2024). In copertina l’illustrazione di Valeria Puzzovio: un signore in giacca e cravatta (supponiamo che sia in cravatta, perché l’inquadratura della scena non ce la fa vedere) con le mani poggiate a un parapetto che dà sullo spazio a fissare le stelle. Quest’ultimo (lo spazio cosmico) segue il colore in copertina del nome dell’autore (Gianluca Furnari), e assume un tono più verde pallido che non nero, come ci aspetteremmo invece dallo spazio. Un verde pallido che da un lato è colore vegetale (erbe, edere), ma che dall’altro è colore della muffa: infatti, nel libro sesto del De Architectura, Vitruvio chiama “pallore” la muffa, e sconsiglia la progettazione di biblioteche che danno a sud oppure ad ovest, dal momento che vi irromperebbero venti freddi che portano con sé “umidos spiritus”, soffi umidi che corrompono i volumi col “pallore”. Anche questo volume, che si chiama “Quaternarium” (l’era del Quaternario, ma con una sfumatura anche del quaterno, del quaderno), sta in una biblioteca con un immaginario che guarda a un ovest/direzione del tramonto totale, la fine della vita per come la intendiamo, con una prospettiva fantascientifica (ci sono astronavi, colonie marziane, forme di vita aliene): e infatti in Quaternarium entra come un vento freddo dell’ovest, un’Aria della fine (Antonio Porta, L’aria della fine, 1982) che porta un po’ di guasto nel sistema libro: “Allora è vero: è falso / il libro della vita” (Charta Creaturarum, pagina 17). Proveremo allora ad immaginare il libro di Furnari come una biblioteca che Vitruvio non approverebbe, vedendo quali altri volumi di volta in volta si affacceranno su questo, con il vento (una semi-cosa) che scompiglia le pagine e le stacca, oltre a corromperle con la muffa; e inizieremo andando dietro proprio alla parola “aria” che nella prima sezione del libro, Ipersonno compare nove volte, di cui sei solo tra pagina 11 e 16: “l’aria / comincia a pruderti in ogni cellula, / ti crescono sul capo peli o piume” (11) ; “Dov’è che vado – gli altri / sotto casa, l’aria strana, ricordano / me, finito da un giorno” (12); “Si chiude, è d’aria in aria / più veloce anche il mio transito” (14); “dirci addio, fondere in bolle d’aria”(15); “al tramonto / volano, appese a una corrente d’aria / scimmie piccole un dito” (16). L’aria è possibilità di respiro e di spostamento: ci si può spostare nell’aria così bene da finire per dissolvercisi, e respirandola mette in moto altre cose a sua volta. Naturalmente, la ricorrenza dell’aria/l’aura/Laura è indice di una poetica petrarchesca. Infatti subito dopo, a pagina 17, troviamo una poesia fantasmatica, che sta dal punto di vista della non-esistenza:
Ma ci pensate, cose
che non siete? Neanch’io, quando ho iniziato
a essere, sapevo essere
e ritraevo dal lago d’immagini le dita
per rimanere insieme a voi;
io nuoto immaginandovi
verso il futuro, finché due miei cari
dicano «Era sereno»
e sarà il giorno di Natale, prima
mia festa di scomparso:
lascio te, corpo; lascio voi, fantasmi
della mente, cadere
come un serto di carta a una bambina;
torno presto da me, vado fra poco
dove non c’è più immagine,
dove dal vento trema la memoria”.
È la prima volta che compare il vento, ossia l’aria stessa messa in moto: impariamo qui che nel mondo del non esistere il vento gioca un ruolo chiave. La parola vento assumerà poi sempre più importanza nel corso del libro: la prima sezione si conclude con una visione desolata della Terra nell’anno 9022, con solo nevischio e “vento antartico”. Non l’aria della fine, ma il vento della fine. Cercando il vento a ritroso lo troviamo anche in Vangelo elementare (Raffaelli, 2015), l’opera prima di Gianluca Furnari:
Ci sembra già di averla tra le mani
la parola non soprannaturale,
molto simile al vento, ma più simile
a sé stessa, in sé stessa confidente,
che non dirà nient’altro che sé stessa
e così dirà il mondo
(qui https://www.poesiadelnostrotempo.it/vangelo-elementare-poesie-di-gianluc... trovate in fondo alla pagina la poesia completa, che va letta tutta per seguire il resto di questo articolo: vi ho avvisati/avvisate) Invertendo il rapporto, il vento è simile alla parola simile a sé stessa che dicendo sé stessa dice il mondo: c’è sempre da fare attenzione alle cose che somigliano a sé stesse, dal momento che “solo quello ch’è vero Ente, il quale, parlando di sé, disse Ego sum qui sum, è in tutto somigliante a se medesmo”, come scrive Tasso nel dialogo del Conte, o delle imprese, circa nel 1594, riprendendo tutta una tradizione filosofica che dai classici prima e poi attraverso Tommaso fa i conti sulla possibilità di assomigliare solamente a se stessi; non stiamo a ripercorrerla, ma è solo per ricordare tutto il peso che sta dietro a un’affermazione come “la parola non soprannaturale, molto simile al vento, ma più simile a sé stessa”, con questo vento che fra da tramite fra il non soprannaturale e il soprannaturale e sta lì a metà strada fra i due termini di paragone (e già che ci siamo rileggiamo e riconsideriamo Cartina di muta di De Angelis: “«Perché fai questo?»/ «Perché io sono così», risponde una forma dura della voce, / un dolore che assomiglia / solamente a se stesso”, la voce e la parola che assomigliano solo a se stesse. E ricordiamo che nel saggio di Foucault su Magritte la parola scritta che assomiglia a se stessa non è capace di dire nulla sulla pipa). Tutto questo per dire il mondo; ma siamo nella penultima poesia di Vangelo Elementare, e il mondo era stato già menzionato nella seconda poesia del libro: “Eravamo / i sogni delle umanità future, / i pionieri di un mondo appena apparso, // la prima generazione di viventi”. Quaternarium da questo punto di vista rappresenta davvero un cambio di paradigma e prospettiva fondamentale rispetto a Vangelo elementare: se, soprattutto nella prima sezione del libro, in Vangelo elementare la prospettiva è su chi sta venendo sognato, in Quaternarium la prospettiva è su chi sta sognando: è il punto di vista sia di Ipersonno che di Z. Inoltre, nel 2021 su Renascens era stata pubblicata un’ecloga in latino di Furnari che con il sonno/sogno di Saladino, l’apprendista di Leonardo da Vinci, fa da anticipo all’io di Ipersonno, al personaggio Z: “Haec tamen ut mulcent aures tibi somnia, somnus / altior obrepsit: dormis, mi blandule! Caeca / te coram ludant aevi simulacra futuri” (“Ma mentre questi sogni ti carezzano le orecchie, un sonno / più profondo ti ha preso: dormi, piccolo mio! Ciechi al tuo / cospetto giochino i fantasmi delle epoche future”), mettendo in mostra con tre versi il meccanismo alla base di Quaternarium: qualcuno sogna le epoche future e ha una visione della non esistenza, un mondo di vento.
II. Calendario marziano
Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.
Dicono alcuni che finirà nel fuoco
il mondo, altri nel ghiaccio.
Del desiderio ho gustato quel poco
che mi fa scegliere il fuoco.
Ma se dovesse due volte finire,
so pure che cosa è odiare,
e per la distruzione posso dire
che anche il ghiaccio è terribile
e può bastare.
(Robert Frost, Fire and ice, 1923, traduzione di Giovanni Giudici)
S'i' fosse foco, arderei 'l mondo;
s'i' fosse vento, lo tempestarei
(Cecco Angiolieri)
La prima occorrenza della parola “mondo” in Quaternarium è a pagina 13: si viene abbandonati dall’anima “in carta e filo” al buio “in un mondo avvenire”, scritto così: non “a venire” ma “avvenire”, tutto attaccato, con tanti problemi: “mondo” come aggettivo (pulito, puro) riferito al verbo sostantivato “avvenire”? “avvenire” inteso come l’azione di avvenire in un certo mondo e avente per soggetto l’io? Oppure avvenire come predicato di mondo, con un cortocircuito della lingua? Io tendo per la seconda ipotesi, dato che prima ci sono altri due infiniti descrittivi/prescrittivi alla Montale. In ogni caso, alla pagina successiva ci si toglie il casco per “respirare / all’improvviso in altri mondi”. Un giro di pagina tra il mondo futuro (e quindi la visione di vento) e gli altri mondi stellari: questa distinzione fra le due possibilità viene appianata dalla seconda sezione del libro, Calendario marziano, dove assistiamo sia alla vita su un nuovo mondo che alla fine di quest’ultimo, il modo in cui il nuovo mondo di Marte viene presentato da subito come “vecchio mondo” rispetto a quello veramente “nuovo” che sta per arrivare.
Non possiamo andare avanti senza prima ricordare che nella parte iniziale del secolo XVII la letteratura italiana registra un leggero sommovimento. Per qualche motivo, a oltre un secolo dall’arrivo nel continente americano, alcuni autori decidono nello stesso arco di tempo di cimentarsi con la stesura di un poema in ottave che abbia per tema la “impresa” di Cristoforo Colombo: Alessandro Tassoni (L’Oceano), Tommaso Stigliani (Il mondo nuovo), Giovanni Villifranchi (Il Colombo), Agazio di Somma (L’America) e altri. Naturalmente, sulla scorta forse anche dell’epistola Mundus novus di Amerigo Vespucci del 1504, proliferano versi sul mondo nuovo: “Cantiam, Musa, l’Eroe di gloria degno, / Ch’ un nuovo Mondo al nostro Mondo aperse” (Tassoni); Perché di là de l’Ocean profondo / troveria fermamente un novo mondo” (Stigliani); “Dar nuovo mondo al mondo” (Villifranchi). In questi casi il mondo nuovo è inteso come alterità completa: una cosa nuova e sconosciuta che si aggiunge al mondo noto, con una concezione veramente al limite dell’extraterrestre: si sprecano i classici paragoni fra allunaggio e arrivo nel nuovo mondo, fra navi spaziali e navi marine. Quindi, quando Furnari scrive nella seconda sezione di Quaternarium: “Intento come tutti all’opera del mondo / nuovo, sotto i fanali / di navi cargo, di autocarri silos” oppure “guardalo: viene: è un mondo / nuovo” (sempre inarcatura fra mondo e nuovo), verrebbe da ricondurlo all’immaginario fantascientifico della raccolta. Invece, a dispetto di quello che potremmo pensare, il nuovo mondo di Furnari non c’entra con quello dei poeti “colombisti” del Seicento o delle avventure interplanetarie post Verne: basta riportare il testo completo della seconda occorrenza del mondo nuovo in Furnari:
Da qualche parte si dovrà ricominciare:
queste coste, le dune
già animate da gran gala di microbi,
terminati in un niente
gli sfarzi immensi della vita,
la sua scienza di vermi –
Guardalo: viene: è un mondo
nuovo, pieno di freddo e si silenzio,
fuoriuscito dalle acque
del grande nulla, Marte
verso la fine dell’Amazzoniano,
test fallito, storia chiusa al transito
finché un lander vi atterri.
Si potrebbero abbinare a questi versi quelli leggermente più recenti, pubblicati ad Agosto 2025, di Giorgiomaria Cornelio, che in L’ufficio delle tenebre fa dire alle “Piccole creature: quelli che restano”:
Perché un mondo nuovo
non è per forza un altro mondo,
ma questo qui, un momento dopo
la sua eclisse.
Il mondo nuovo di Furnari e Cornelio non è il piano B (infatti: There is no plan B; e il trittico intitolato Piano B di Quaternarium non lascia speranze circa la sopravvivenza della nostra specie) rispetto al piano A di questo mondo, ma ne rappresenta piuttosto uno sviluppo; o una successione. Tornando ai poeti del mondo nuovo del Seicento, può essere interessante chiudere il discorso ricordando che Torquato Tasso, il più grande punto di riferimento per tutta questa gente che scriveva poesie, non aveva mai inscenato grandi viaggi oltreoceanici (se si esclude il viaggio fantastico per raggiungere il Giardino di Armida). Nonostante questo, scopriamo che anche lui ha scritto versi sul mondo nuovo: “Tu le cagioni a me del nuovo Mondo / rammenta ormai, Prima Cagione Eterna” ; “Ciascun per sé, colla sua mente indietro / ritornerà, pensando al primo tempo / che ebbe’l principio e’l tempo il nuovo Mondo”. Tuttavia, questi versi provengono dalle Sette Giornate del Mondo Creato (1607): il nuovo mondo è il nostro, quello della creazione che Tasso si era prefissato di rievocare in endecasillabi sciolti. Qui si toccano il poema esameronico dei giorni della creazione e quello di argomento marittimo-avventuroso delle Americhe, il mondo dopo la fine del mondo e gli altri mondi spaziali. Nella sezione Calendario marziano Z. vive da vicino questo problema: sta già nell’altro mondo, Marte, ma sente comunque l’aria della sua fine; anche se dovremmo parlare piuttosto di vento che non di aria, come nella seconda poesia della sezione:
mi sente uno dall’altra
parte del cielo, tra la folla in ghingheri
pensa «è il vento», ritorna
nel nulla a festeggiare
Il vento della fine assomiglia allora a una voce (ricordiamo che la parola era molto simile al vento), che sposta gli elementi e li rimescola:
Alta, a onde, urta sui tetti
della città la polvere,
piove lungo le vie.
C’è una “tempesta di polvere” su Marte mentre Z. porta avanti una psicomachia assistendo alla discussione fra due “messi celesti” Z1 e Z2, che arriveranno a parlare di piccioni; ma dietro alla tempesta sta il vento, ed è lui a sollevare la polvere. A tale riguardo esiste uno strambotto di dubbia attribuzione a Serafino (messo celeste) Aquilano (uccello, piccione) (XV secolo), sempre sulla polvere sollevata dal vento in mezzo agli edifici:
Porta la polve el vento in su le torre,
et ben che in alto sia polver se stima:
poi presto presto con furor ricorre,
et la riporta in terra, ove era prima.
Così questa fortuna ognor discorre:
ora t'abbassa, et or ti porta in cima.
Ma se tua gran beltà mha sì sommerso,
sapi che ogni diritto hà il suo riverso.
Anche qui la polvere sollevata dal vento porta un capovolgimento: la cosa bassa che arriva in alto prima di ricascare, il rovescio che coincide col diritto, ma in un’illusione; tanto che nella poesia conclusiva del breve ciclo dei due messaggeri Furnari richiama in causa la sua precedente produzione poetica. Nella prima stanza Z1 menziona “il ragazzino che sognava / la luce dove io scrivo”, che rischia di essere svegliato dal più minimo brusio: e basta guardare alla prima poesia di Vangelo elementare per capire che questo ragazzino che sogna la luce coincide col Furnari autore del suo primo libro:
Il primo appuntamento fu alla luce
nell’ora della luce:
fu in quello spazio pieno
la coagulazione delle voci,
lo svegliarci l’un l’altro -
divisi da ogni cosa – in ogni cosa
a una stessa distanza da ogni cosa;
il nostro primo nascere (il vedere)
fu quel manifestarsi nella luce
in nome della luce.
Ed è probabilmente a questa poetica che il messo celeste Z2 risponde:
L’aria fredda ha ragione. Esci da questa
lirica. Torna in te.
È l’aria fredda della fine che fa uscire Z. dalla poesia di Vangelo elementare, che aveva però già anticipato il proprio rovescio nella poesia conclusiva della raccolta
Noi ci saremo
Quando un’aurora nera avrà incendiato
le ultime reliquie della luce,
quando un corteo infinito fenderà gli spazi
dietro al cadavere del nostro Sole
e i suoi pianeti andranno come figli
disturbati (ma chi ti ha ucciso, padre?),
noi ci saremo.
L’ultima poesia del libro precedente aveva già in sé l’ambientazione cosmica della fine dell’universo: Quaternarium prende allora le mosse esattamente da dove Vangelo elementare aveva scelto di fermarsi. Il vento della fine continua a soffiare nella biblioteca/libro e a portare il pallore: “un vento di rabbia e reticenza” avvolge i botanici che assistono impotenti, nella fantasia di Z., alla fine della vita vegetale, tanto che “l’aria è il mare; la civiltà si libra / in una pace precambriana / e ricomincia”. Il “mondo / nuovo, pieno di freddo e si silenzio” che riparte dall’aria. Non sorprende che un momento determinante della storia di Z. sia legato al cimitero degli ologrammi: gli ologrammi sono luce nell’aria, e non a caso, sulla scorta dei piccioni e degli altri volanti (anatre, scimmie, creature protiste, ornitotteri leonardeschi), anche Z. sogna di prendere il volo e darsi all’aria.
III Quantum Nova
Dentro dal cerchio, a cui intorno si gira
(Boccaccio, Rime)
nell’aria intatta
ora a cerchio lo sguardo la perdita lo svela,
un parallelepipedo di una battaglia navale
del settecento
(Patrizia Vicinelli, Il cavaliere del Graal)
Quando Furnari nella prima poesia di Vangelo elementare scrive “divisi da ogni cosa – in ogni cosa / a una stessa distanza da ogni cosa” sta riattivando (non ci interessa se l’abbia fatto apposta oppure no) uno dei passaggi più oscuri della Vita Nova, quando compare Amore a Dante e gli dice Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiae partes; tu autem non sic: io sono come il centro del cerchio, in riferimento al modo in cui tutti i punti della circonferenza sono equidistanti, stanno alla stessa distanza, dal centro; ma tu (Dante) non sei così. Effettivamente Vangelo elementare ha qualche elemento di circolarità: il tema del ritorno, la ricorsività insita nella reiterazione che il tempo grammaticale dell’imperfetto porta con sé, o il fatto che cominci con la luce (come la Genesi) e si chiuda con la fine dell’universo; ma è come se nel passaggio dal primo libro al più recente fosse cambiato qualcosa nella forma di questo cerchio e fosse andato assomigliando sempre di più, schiacciandosi, a un’ellissi: un’orbita, o uno zero. Oltre ad alcuni testi online del 2016 e del 2018 (https://www.luigiasorrentino.it/2018/07/22/gianluca-furnari-senza-titolo/ ; https://www.luigiasorrentino.it/2016/09/04/gianluca-furnari/ ) ancora inediti ma già con qualche anticipo della svolta interplanetaria di Furnari, a metà strada tra Vangelo elementare e Quaternarium ci sono due poesie che si trovano nel secondo volume dell’antologia Poeti italiani nati negli anni ’80 e ’90 a cura di Giulia Martini (2020), e che, per quello che ne so, si possono leggere soltanto lì. Nella prima si tratta di due figure distanti “fuori dalle ere”, lontane duemila anni, che un giorno verranno ricongiunte in un’ampolla (immaginario vagamente alchemico):
Torneremo
dentro l’ampolla, nudi, sicut erat
in votis: ogni ipotesi discorde
sarà provata insieme:
due che presero luce ad occidente
salvi all’ora del tempo, un solo uomo.
Sicut erat in votis è espressione latina ripresa da Orazio in una satira in cui si contrappongono città e campagna raccontando anche la famosissima storia del topo di campagna e del topo di città: due amici da due mondi davvero distanti “ere”, che prendono a orbitare dentro l’ampolla (una sfera di vetro, o comunque con una certa rotondità) prendendo luce “ad occidente”; quindi dal tramonto; quindi mentre il sole cala; quindi alla fine della giornata, del tempo. Anche l’altra poesia dell’antologia è protesa verso questo alter fantasmatico, e anche questa si chiude con una unione, una possibilità di incontro alla fine del mondo. A livello stilistico, rispetto a Quaternarium e Vangelo elementare si sente molto Alessandro Ceni:
Allora dovrò uscire, lapidare i vivi e i morti.
«Guai a voi, figli persi,
che centosette piedi
fregando andate per i fondi vieti
verso le tre – se il tempo, il tarlo viva
di voi, che è già di me vissuto –
se vi si bruci il bacio a un tratto
in un atto unico, come per me a quel giro
sotto chissà che razza di comete.»
È per te questa strage, mio pupazzo
infruttuoso. Te ne accorgi?
È per poterci tendere la mano
da buoni; e poi l’insidia
un’altra volta, e un’altra, poi, la mano.
Leggendola ci immaginiamo il cerchio delle mani tese e ritratte in successione; mi sembra quindi che lo scarto nella poetica di Furnari tra Quaternarium e Vangelo Elementare dipenda dalla concretezza sempre maggiore assunta dall’interlocutore fantasmatico. In Vangelo elementare era rappresentato dalla figura paterna, mentre negli inediti dell’antologia va diventando qualcosa di diverso, che si sottrae completamente dall’esperienza essendo distante miglialia di anni e che quindi non è mai stato incontrato: è il banco di prova di Ipersonno, di Z. che finisce fuori dal tempo, con una dinamica che fa venire in mente l’apertura cosmica di Alla sua donna di Leopardi, un interlocutore sconosciuto talmente distante da diventare fuori dal tempo e dallo spazio:
Se dell’eterne idee
L’una sei tu, cui di sensibil forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita,
E fra caduche spoglie
Provar gli affanni di funerea vita;
O s’altra terra ne’ superni giri
Fra’ mondi innumerabili t’accoglie,
E più vaga del Sol prossima stella
T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi.
A questo punto bisogna chiedersi cosa succede quando si finisce fuori dal tempo. Restando nell’ambito della tradizione letteraria italiana, a venirci in aiuto arriva Petrarca: sta in esergo a Quaternarium, e in quest’ultimo compare in una biblioteca su Marte un codice bellissimo dei Fragmenta. Anche se finora, con questa storia di aria e fantasmi, abbiamo evocato allusivamente il Petrarca del Canzoniere/Rvf, per entrare nell’ultima sezione di Quaternarium abbiamo bisogno del Petrarca dei Trionfi/Triumphi. Se i Trionfi sono strutturati in un crescendo, di processione in processione (Dante si muove e va a vedere; Petrarca sta fermo e vede passare), Quaternarium invece è strutturato come un conto alla rovescia: le tre sezioni sono un 3, 2, 1… prima della fine dell’universo. Nei Trionfi tutto sembra finito al quinto trionfo, quello del Tempo che, come è risaputo, non risparmia nulla; non fosse che il sesto trionfo, quello conclusivo, è il trionfo dell’Eternità, quindi di ciò che sta al di fuori del tempo. Ecco come Petrarca racconta la fase finale della visione:
Questo pensava; e mentre più s’interna
la mente mia, veder mi parve un mondo
novo, in etate immobile ed eterna,
e ’l sole e tutto ’l ciel disfar a tondo
con le sue stelle, ancor la terra e ’l mare,
e rifarne un più bello e più giocondo.
Anche qui il mondo (a capo) novo che arriva dopo che il sole, il cielo e le stelle sono stati disfatti “a tondo”, a zero, per rifarne uno nuovo; siamo vicini all’ “opera del mondo / nuovo” di Quaternarium, al mondo dopo l’eclisse di Cornelio. In Furnari questa distruzione passa attraverso la lingua: la scelta del latino per l’ultima sezione, Quantum nova, trasmette la materialità di questa lingua che si dissolve insieme al mondo, come succede anche per Petrarca, che a questo punto, dovendo dare l’idea di come viene tutto bene davanti all’eternità, al fuori dal tempo (a ciò che assomiglia solo a se stesso) mette in scacco la lingua attraverso le singole parole:
né «fia» né «fu» né «mai» né «inanzi» o «’ndietro»
[…]
Quel che l’anima nostra preme e ’ngombra,
dianzi, adesso, ier, diman, mattino e sera,
tutti in un punto passeran com’ombra;
non avrà loco «fu» «sarà» ned «era»,
ma «è» solo, in presente, et «ora» et «oggi»,
e sola eternità raccolta e ’ntera.
In Quantum Nova succede la stessa cosa:
Ecce, quark quaternio
quatitur ac nubi
cedit mundus. Desinunt
quando, quid et ubi.
Ecco, vibra il quaderno
dei quark e l’universo
cede a una nube. Cessano
il quando, il cosa, il dove.
Non è ineffabilità, ma fine delle parole; non è scacco, ma obsolescenza. Raccontando questa de-creazione in latino e seguendola lungo l’arco di cinque giorni, Furnari da un lato attiva l’immaginario biblico ribaltando i sette giorni della Genesi; ma dall’altro lato, che è anche quello più interessante, si rifà alla tradizione liturgica delle sequenze latine medioevali, come il Dies irae (ricordiamo che in Quantum nova l’azione è scandita in I Dies, II Dies etc) il Pange lingua. In questo modo Furnari costruisce una liturgia per la fine dell’universo, sulla scorta del modello medioevale. Basta confrontare l’inno Solemnis hac festivitas, con tanto di quartine rimate, e le ultime tre quartine di Quaternarium:
Solemnis haec festivitas
Novum instaurat gaudium,
Qua perennis felicitas
Proponitur in praemium.
Christus scandens in aethera
Mortis fregit potentiam;
Sedens Patris in dextera
Jugem parat laetitiam.
Dies per multos saepius
Suis vivus apparuit;
Et comitum cor durius
Mitis magister arguit.
Da Quantum Nova:
Aevi sub egelidis
ventis ipse vidi
ultimo zephyrium
Zephirum elidi.
Quo te, globosissime
numerorum, ore,
quo te anam, unice,
mortis in candore?
Satis. Scribat calamus:
«Cessat aetas Quarta».
Splendeat Quinarius.
Congeletur charta.
Che in traduzione suona:
Ho visto con i miei occhi
elidersi lo Zero-
zefiro sotto i venti
gelidi dell’eterno.
Con che voce dovrei
cantarti, rotondissimo
numero unico, chiuso
nel bianco della morte?
Basta. Scriva la penna:
«Fine dell’età Quarta».
Riscintilli il Quinario.
Sia ibernata la carta.
Siamo dovuti arrivare alla fine del libro per dare un nome al vento della fine che si presagiva dall’inizio, ed è lo Zefiro, in cui Furnari fa risuonare il suono dello Zero nel testo latino. Lo Zefiro è uno dei venti temuti da Vitruvio: arriva da ovest e porta soffi dannosi per i libri se le biblioteche hanno le finestre nei posti sbagliati. La biblioteca di Quaternarium è come l’immagine in copertina e non ha pareti, quindi la finestra è letteralmente uno zero e ci passa attraverso quello che vuole. In questo caso, l’operazione che Furnari porta avanti consiste in un capovolgimento del ruolo tradizionale dello Zefiro, che tra XIV e XVII è ultra citato in quanto brezza che annuncia a fine inverno l’arrivo di un tempo più piacevole, quello primaverile. Ecco Petrarca: “Zefiro torna, e ’l bel tempo rimena”, Ottavio Rinuccini: “Zefiro torna e di soavi accenti / l’aer fa grato e il piè discioglie a l’onde”, Aurelio Aureli: “Zefiretti che spirate / dolci fiati a me d’intorno”. Ma in Quantum Nova lo Zefiro non arriva per annunciare la primavera, e segna invece l’arrivo di un inverno perpetuo. Così l’ultima nota di Quaternarium è disperata e senza fiducia nel dopo: la carta va ibernata non si sa bene perché, ed è buona solo a scrivere la fine di se stessa, la propria morte come lo zero “chiuso / nel bianco della morte”. Viene da pensare che la parola molto simile al vento ma più simile a se stessa di Vangelo elementare sia la non-vita, la non-esistenza (la parola simile solo a se stessa di Foucault alla fine non era capace di dire nulla di vero sul mondo, a parte dire di non essere capace di dire nulla); che per mettere a fuoco questa parola Furnari non abia fatto finire solo il sistema solare, ma tutti i mondi possibili. Infatti, nonostante nel libro ci siano gli spunti per pensare a mondi alternativi con altri tipi di vita dopo la fine, è evidente che nessuno di questi potrebbe resistere all’ultimo giorno della de-creazione, alla visione finale dello Zero e dello Zefiro che completa l’elisione totale. A questo punto veramente ci chiediamo: come si può andare avanti dopo un libro così? Mantenersi su questa linea fantascientifica sarebbe un passo indietro rispetto al discorso portato avanti da Quaternarium, che fa da zero e annulla se stesso e tutto quello che lo ha preceduto. L’unica possibilità che in questo momento mi sembra di vedere parte dagli inediti nell’antologia, in particolar modo nel primo, che nella parte centrale, dopo aver “aperto” la comunicazione con il “fratello impossibile” fuori dalle ere, arriva a questo punto:
che se mi faccio in quattro per trovarti
sui miei teoremi, tu non so che cosa
ti metti in tasca al buio
che me li manda in aria duemila anni
dopo. Fammi parlare, frater
delire, hai già passato il segno: siamo come
quei due nella caverna,
tolri da un sogno a mezza sera: che, per essere
l’uno l’eco dell’altro,
non si potevano spiegare;
che non era acqua l’acqua, la parola
stava sotto le polveri avvenire.
Qui troviamo associato a polveri “avvenire”, come nella quinta poesia di Quaternarium, in cui “avvenire” veniva associato a “mondi”: “polveri avvenire” e “mondi avvenire” (che sappiamo essere quelli dopo la fine della vita) si toccano, e sotto questi sta “la parola”, che ovviamente leghiamo alla parola molto simile al vento ma più simile a se stessa, in se stessa confidente, che non dirà nient’altro che se stessa e così dirà il mondo etc. La poesia continua rimettendo la distanza fra i due, con una caduta attraverso l’aria e i poli del pianeta che anticipano gli sviluppi di Quaternarium:
[…] se cadi
da polo a polo, come fai, che l’aria
ride di te, che sente sulle piazze
crescerti la premura –
cosa non può la terra, quanto resta
ancora da provare all’orditore, al padre
chino sul nostro sogno?
Oltre al sogno, che col senno del poi ci rimanda a Quaternarium e al sogno del futuro di Saladino, il “padre” ci riporta alla poesia di Vangelo elementare: quindi questo testo, dopo lo slancio iniziale, viene ricondotto sia a sviluppi allora futuri, ma che oggi sono stati esauriti da Quaternarium, sia a temi già trattati nell’opera prima. Rimane però ancora uno spazio di azione alla poesia di Furnari, che arriva dalla zona centrale di questo testo: anche dopo aver letto Quaternarium e Vangelo elementare, c’è una domanda senza risposta: che cosa si è messo in tasca il doppio
[…] tu non so che cosa
ti metti in tasca al buio
che manda in fumo tutti i piani del soggetto della poesia? Forse esistono altri testi che con questo comporrebbero un ciclo coerente. Una traccia continua potrebbe essere l’oro, che compare sia in questo (“Eppure se vuotando / tre fiaschi d’oro doppi”) che nel successivo (“l’asino / d’oro sul tavolo”, Apuleio?), ma è un tentativo di indovinare che va a vuoto. Mi sembra però che negli sviluppi futuri della poesia di Furnari ci sia posto per una poetica incentrata sul cercare di mettere a fuoco questo oggetto messo in tasca al buio, quindi senza luce (Vangelo Elementare è il libro della lux, luce divina, Quaternarium il libro del lumen, luce percepita ): qualcosa di inerte come un mondo finito, che viene maneggiato al buio e poi nascosto in tasca (una doppia copertura), ma che per quello che sappiamo potrebbe persino essere dorato, e che nonostante tutto, pure nella sua inerzia riesce a mandare “in aria” i piani del futuro, e tra questi forse bisogna contare il finale perfetto di Quaternarium, che non lascia nessuna possibilità d’azione; non fosse per questo oggetto indefinito che sta nel passato ma che potrebbe cambiare tutto, statico come la carta ibernata che chiude il libro. Tenendo presente che non sappiamo se questa verrà congelata davvero, così come non sappiamo se la penna scriverà veramente “fine dell’età” dato che “congeletur” e “scribet” non sono verbi al modo indicativo/denotativo, ma sono due congiuntivi esortativi che esprimono un comando, delle istruzioni, un teorema che, come da consuetudine, in latino viene descritto col congiuntivo: “Ducatur enim recta A K, parallela ipsi B E, vel ipsi C D, secans B C, in L, et iungantur rectæ A D, A E, C F, B H” (inizio della dimostrazione del teorema di Pitagora negli Elementi di Euclide, dall’edizione commentata da Christophorus Clavius del 1574); “che se mi faccio in quattro per trovarti / sui miei teoremi, tu non so che cosa / ti metti in tasca al buio / che me li manda in aria duemila anni / dopo.” Scritto il congiuntivo esortativo, non è detto che il comando sia poi stato eseguito: e così nel sistema poetico di Furnari persiste davvero la possibilità concreta che questo oggetto guasti tutto il piano perfetto per la fine dell’universo, e che estraendolo o cercando di estrarlo dalla tasca si aprano nuove prospettive per la sua poesia. E questo ipotetico terzo libro di Furnari, che immagino né lux né lumen ma lucor, luce diffusa da un centro che perde di intensità (che si fonde al buio nei suoi confini), ricordando che la parola latina lucor, come questo libro che ipotizziamo, non esiste perché non è attestata, ma solo ricostruita per via etimologica a partire dal volgare lucore, penso che per esergo dovrebbe avere questa poesia di Alessandro Ceni da Mattoni per l’altare del fuoco, con oggetti in tasca che vengono estratti e astronavi tra il giocattolo e l’aereospaziale:
Tu che non sei di questo mondo e sei nella polvere
e siedi alla parte breve del tavolo
estrai dalla tasca il bosco e dal bosco te stesso,
coi tuoi pensieri stesi ad asciugare sul greto
del fiume essiccato come cordicelle annodate
da un bambino estivo, che raso sull’erba
scocchi festuche marine alla terra e
al passo dei tordi protetti la prua di pigne
del promontorio nel ceduo del mare aperto,
dove al medesimo intento le cieche aringhe
migrano e sprofondano.
Semplicemente, in una radura nel bosco,
cucita alla fronda più alta la civetta inchioda
alle loro piume come a peccati falangi d’uccelli,
schiere di alati perduti, cori di rimprovero e di pianto
mentre tu avvicinandoti alla nave spaziale
giunta infine a riprenderti fai il gesto
di estrarre anche questa cosa dalla tasca.
