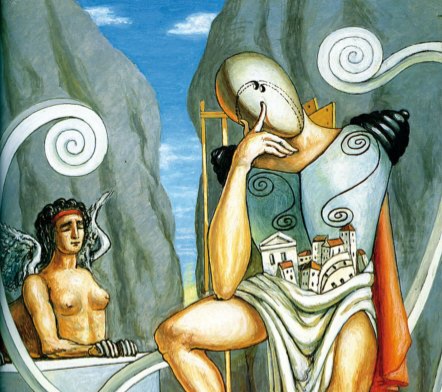
In estate è possibile sapere con certezza assoluta quali saranno i versi “contemporanei” più letti ogni settimana. Costano meno di una plaquette (2 euro) e sono più diffusi dei “La grande poesia” di Repubblica, anche se condividono lo stesso spazio di reperibilità. Se dovesse per caso venirvi voglia di procurarveli, forse non dovreste nemmeno acquistarli: è probabile che in questo momento siano già nelle mani di un vostro parente; a Ferragosto questa probabilità si farà certezza. Oltre a essere i versi contemporanei più letti, sono probabilmente anche quelli più appuntati: a penna, a matita, a pennarello. Per chi non avesse ancora colto: stiamo parlando della Settimana Enigmistica (ogni giovedì in edicola, da 94 anni; questa settimana esce il numero 4870) che non contiene soltanto parole crociate, rebus e vignette, ma anche poesie. Infatti, la terza pagina di ogni numero, “La pagina della Sfinge”, raccoglie tutta una serie di giochi enigmistici del linguaggio (bifronti, lucchetti, sciarade, scarti, biscarti, zeppe, anagrammi, scambi sillabici, cambi di vocale e consonante) che devono necessariamente essere articolati in una forma metricamente consona. Tendenzialmente in questa terza pagina abbiamo a che fare con endecasillabi con rime occasionali, soprattutto nel distico finale, come in questo caso (tutti gli esempi che riporto vengono dal numero 4389, 5 Maggio 2016, per non diffondere nessun componimento più recente):
8916 FALSO ACCRESCITIVO
Che incubo!
La scorsa notte un brutto sogno ho fatto:
un xxxx [prima parola da ricavare per risolvere l’enigma, ndr] minacciava di mutarmi
di punto in bianco in un peloso ratto.
All’istante mi sono risvegliato
ed ero rattristato - che xxxxxx [il falso accrescitivo da risolvere, ndr]! -
per quella prospettiva assai tremenda.
Sarebbe stata infatti una faccenda
molto intricata, senza soluzione
per un ereditario mio retaggio:
sempre son stato allergico al formaggio.
(Mr. Wise)
Qui per mettere in piedi l’enigma basterebbero solo i primi sei versi; i quattro conclusivi sono inclusi per puro gusto della scrittura, per completare le rime (“soluzione” rima con il falso accrescitivo che non divulgo), e l’immancabile chiusa in rima baciata conferisce a questo componimento (e ad altri) un’aria madrigalesca o quasi da ottava quando la narratività, come in questo caso, si fa particolarmente marcata. Ci sono alcuni problemi a livello retorico, in primis anastrofi e troncamenti che sanno un po’ troppo di “licenza poetica” ma che, insieme a qualche zeppa (non enigmistica) per portare a 11 il computo, sarebbe possibile correggere per rendere il testo più scorrevole. Per esempio: l’ultimo verso “sempre son stato allergico al formaggio” suonerebbe molto meglio come “sono da sempre allergico al formaggio”, eliminando quel “son” che risulta un po’ forzato.
Ma non appena passiamo a pagina 6, “Appendice alla pagina della sfinge”, finisce il dominio dell’endecasillabo e diventano possibili altre forme metriche. Dai classici settenari e ottonari:
8920 ZEPPA SILLABICA
Famosi veneti
Gran scultore fu Xxxxxx,
grande amante Xxxxxxxx.
(G. Esposito)
a misure più complesse da gestire a livello ritmico, come nel caso di questo notevole uso del senario sciolto:
8934 ANTIPODO
E’ figlio d’arte
Valente sciatore,
muscoloso e aitante,
ha vinto sei xxxxx
(ambiti trofei)
in un’esaltante
stupenda carriera.
Proviene comunque
da un ottimo xxxxx:
suo padre Gilberto [qui l’assonanza è un indizio],
nello sci di fondo,
divenne a suo tempo [di nuovo un indizio]
campione del mondo.
(Di Strepeis)
Non stiamo facendo queste osservazioni per pedanteria o per dare sfoggio di quelle che sappiamo benissimo essere solo nozioni basilari di metrica. Quello che ci preme evidenziare è il modo in cui il riconoscimento del pattern metrico proposto in ogni componimento poetico-enigmistico diventi essenziale per risolverlo, al punto che spesso si trovano le parole mancanti usando più l’orecchio che la testa. L’ottonario, il settenario, l’endecasillabo chiedono determinati accenti in determinate sedi, e quando la parola da scoprire occupa una di queste sedi è come se conoscessimo già l’accento mancante, il suono che dovrebbe avere e che nei fatti è la prima verifica a cui sottoponiamo l’ipotesi di soluzione: a ritmo torna o non torna?
L’idea che vogliamo trasmettere è che la pagina 3 (ma anche la 6, la 45, la 40) è da 94 anni una palestra metrica in cui affinare l’orecchio con poesie concepite ad hoc per spingerlo a colmare i vuoti. Che si possa usare la categoria “poesia” per questi testi mi sembra fuori discussione: sono scritti in versi, e a voler mettere i distinguo “poesia - non-poesia” ritorneremmo a Croce che nel 1933 aveva pubblicato i suoi scritti su “Poesia popolare e poesia d’arte”, segnalando come persino nel caso della poesia popolare si potesse trovare della poesia e della “non-poesia”. Questo è significativo perché nel 1932 (un anno prima) il 23 (32 invertito; coincidenze?) Gennaio era uscito il primo numero della Settimana Enigmistica, la cui storia non è certo un mistero (qui informazioni: https://it.m.wikipedia.org/wiki/La_Settimana_Enigmistica ). Viene voglia di andare a consultare il primo componimento della Pagina della Sfinge, sempre a pagina 3, che riporto qui di seguito:
POLISENSO
Chi sono? È presto detto:
molle m’adagio in glauca distesa,
e a lungo Maometto
del suo vessillo mi recò l’offesa.
Amo i recessi ombrosi,
il folto di foreste inviolate,
e lungi dai curiosi
passo dormendo intere le giornate.
Quieto, silente, oscuro,
le scheletrite braccia alzando al cielo,
spezzando il limo impuro,
vivo di nuove altezze sempre anelo.
In alto, in alto sempre
l’estro mi trasse per sentieri arditi.
Cantai di balde tempre
l’audaci imprese ed i guerreschi inviti.
Ma perché sei passato
bel tempo delle dame e i cavalieri?
Ora sono diventato
un groviglio di numeri e di zeri.
Pure, seppur bersaglio,
a fieri colpi, non si piega o spezza
mia ferrea tempra, e al maglio
la salda oppongo indomita fierezza.
Rispetto a quanto troviamo oggi nella rivista, questo testo di sei stanze ciascuna di quattro versi, un settenario e un endecasillabo alterni con rima alternata (in modo tale che il settenario rimi con l'altro settenario e l'endecasillabo con l'altro endecasillabo) è sicuramente al di fuori di quello che ci aspetteremmo. A curare la pagina, leggiamo, è stato “Artù”, Andrea Gallina, che aveva pubblicato una decina d’anni prima un bellissimo vademecum per l’enigmista sotto il nome “Nembrod” (e qui la parabola di Gallina, da re a re, Nembrod re della torre di Babele diretto responsabile della confusione delle lingue e Artù, sovrano di profezie e ritorni). Coi suoi quattro componimenti Artù esibisce una piacevole varietà, soprattutto nei temi: un testo un po’ “cavalleresco” (e “Artù” come nome d’arte sembra sottolineare questa atmosfera fantastico/guerresca, tra “braccia scheletrite” alzate al cielo e le “audaci imprese”); una sciarada in quartine di endecasillabi, “Nella fornace” di argomento militare (con tanto di collina tinta del sangue dei soldati, una “bajonetta” e il grido “Savoia!”); un componimento amoroso sempre in quartine che, con tanto di Xxxx, sembra qualcosa che potrebbe tranquillamente uscire nel prossimo numero della Settimana Enigmistica; e infine un piccolo idillio in tre strofe un po’ “barbaro” (nel senso di metrica barbara”) costruito seguendo una struttura preziosa con un gioco di rime (di cui una interna!) su un andamento dattilico composto da un novenario, tre senari, un novenario e un senario doppio con il secondo tronco:
ANAGRAMMA (8)
Dal fitto cespuglio fiorito,
piccino cantore
dell’aria signore,
il trillo gradito
tu levi, che loda natura
che svela la pura - tua gioia d’amor.
Nel limpido specchio movendo,
signore lucente
di piana silente,
tu vivi tacendo;
e célano pudiche l’onde,
le tristi o gioconde - tue brame del cor.
Nei molli fioriti declivi,
nei teneri prati,
i giorni beati
tu candida, vivi.
E scorri la vita serena
ignota alla pena - ignota al dolor
Ovviamente queste poesie di Artù sono anche degli enigmi, e in quanto tali prevedono soluzioni che non sta a me fornire. Mi preme però sottolineare ancora la perizia compositiva dietro a questi componimenti (di nuovo: non li si può che definire poesia), e che ci consentono di tracciare una linea di produzione poetica che va avanti da quasi un secolo, con varianti che si potrebbero tracciare (e che forse sono state tracciate a mia insaputa), chiedendosi per esempio come si sia arrivati alla consuetudine del distico baciato finale, completamente assente in questo primo numero (quando avrà fatto la sua comparsa?). Mi fa pensare alla nobilitazione del rebus che è stato ricondotto tramite certe pose, ambientazioni e oggetti all'emblematica rinascimentale e post, dal Polifilo fino a Bocchi, Alciato, Ripa e oltre, anche tramite il contributo di Eco, e mi chiedo come mai una cosa simile non sia accaduta per questi componimenti che, a fronte della loro popolarità, non vengono menzionati nelle trattazioni sulla poesia italiana contemporanea.
In poche parole: ai non enigmisti appassionati di poesia ricordo che le poesie della Pagina della Sfinge sono quelle che oggi godono di maggior circolazione in Italia (in tutte le edicole tutte le settimane, e con una ricca comunità alle spalle, come si può dedurre anche solo dal numero da capogiro di differenti nomi d’arte che firmano i componimenti), e li esorto a chiedersi anche come mai questo esempio di letteratura a tutti gli effetti ergodica (non ergotica; ergodica, qui informazioni: https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/ergodico/18490 ) sia così vitale. Invece, agli enigmisti appassionati della Pagina della Sfinge chiederei di diventare un po’ più appassionati di poesia, dato che scrivono poesie, anche attraverso piccole accortezze che possono andare da una maggiore attenzione alla sinalefe o altre questioni metriche (utilissimo G. Beltrami con “Gli strumenti della poesia”, un libro piccolino che però contiene le risposte a tante domande sulla metrica, come il tremendo problema: quante sillabe metriche hanno mio, tuo, sua, io, paura? oppure “Dio e io”? Il Beltrami è lì per salvarci da questi dubbi e aiutarci a trovare una quadra, una coerenza quantomeno interna), fino a una ancora più azzardata volontà di sperimentazione, scrivendo come Artù poesie che siano composte da versi con misure diverse ma con una logica ritmica coerente, magari con qualche incursione nella metrica barbara (e qui i primi maestri sono Chiabrera e Carducci), ragionando più per distanze tra accenti che per numero di sillabe. Questo sempre per via dell’importanza che ha il metro in questo tipo di giochi, e per il modo in cui sono capaci di fungere da vera e propria palestra per l’orecchio, come dicevamo prima; che ha quindi bisogno di riservarsi uno spazio per qualche sfida più complessa che lo stimoli al massimo delle sue possibilità e quel pochettino oltre queste ultime che consente di crescere. Mi rendo conto, o forse solo in minima parte, della difficoltà di questa esortazione; ma, legandoci al discorso di Fortini su oscurità e difficoltà (qui: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f16-1f1f-2860-e053-6605fe0a460a/A_Giannino.pdf&ved=2ahUKEwjtjMuVvc2OAxUr8LsIHWd9Ms0QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0tOWbMhZ72EKOAyR7FOIGq ) in poesia, la difficoltà “si pone come enigma provvisorio risolvibile mediante determinati strumenti”: e in materia di enigmi non penso che gli enigmisti difettino di strumenti.
Immagine di copertina: Giorgio de Chirico
